
L’avanzare dell’età mi ha stimolato il conoscere caratteristiche di argomenti diversi.1Per Cerreto e Pietraroja, ad esempio, ho appreso di manufatti architettonici, commemorativi, apotropaici e scaramantici; cfr. R. Di Lello, in “Almanacco”, Istituto Storico Sannio Telesino (ISST) 2020 (1), 2021 (3), 2024 (1), passim. Nel 1943, durante l’ultima guerra, da rifugiato in montagna, a San Potito Sannitico, udii il vocabolo “angìnu”, “piròcca”, “vingiàstru”, “mazzòcca”; l’ho riudito da studentello convittore a Cerreto Sannita, negli anni Settanta a Pietraroja e nel 1983 a Guardia Regia. Ho indagato, finalmente, dall’inizio dei miei 89 anni, per apprenderne l’eventuale importanza e ho acquisito qualcosa che mi sembra non superfluo riportare, al solito in breve e “a la bona”– cioè in modo semplice – per il lettore interessato e perché voglia aggiustarvi inesattezze e ampliare il testo. Ebbene, sul massiccio del Matese,2Per il territorio, cfr. Dante B. Marrocco, Piedimonte Matese, ivi, ASMV, 1980, cap. XXVI, Il Matese, pp. 445-477. sito in due regioni e quattro province, “angìnu, piròcca, vingiàstru e mazzòcca” sono, in genere, varianti dialettali del “bastònu” – bastone – e ne indicano nel particolare, per forma e origine: il tipo flesso in cima e quasi sempre adunco, l’esemplare con apice a pera, la bacchetta di vinco, la mazza grossa e con grande estremità tondeggiante. Questi arnesi, in legno, alti e con sommità elaborate, ai quali si allude comunemente, competono al pastore: i primi tre al “capràru” e al “pecuràru” – capraio e pecoraio –, il quarto al “vaccàru” – vaccaio –;3Per i detti termini in vernacolo ed altri, cfr. Bruno Migliorini, Vocabolario della lingua Italiana, Torino, G.B. Paravia & C., 1965, pp.139, 222, 799-800,1547,1602-1603. CC.VV., Nuovissimo Dardano. Dizionario della lingua italiana, Roma, Curcio, 1982, pp. 1829, 2335-2336. F. Galiani, Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, Napoli, Porcelli, tomo primo, 1783, p. 17. Raffaele Andreoli, Vocabolario napoletano italiano, Torino, 1887, Pozzuoli-Napoli, De Marco, 1993, pp. 26, 293. R. Di Lello, Aspetti della cultura agricola e pastorale sul Matese, “Annuario 1979”, Piedimonte Matese, Associazione Storica del Medio Volturno, 1979, p74 in 64-85. AA.VV., Guardiaregia, a c.d. Pietro Vecchiarelli, Campobasso, Lampo Ed., 1982, pp. 95 e vid. pp. 98 e 129. Elena Cofrancesco, La parlata cerretese ‘L c’rratèen, Cerreto Sannita, Associazione Socio Culturale Cerretese, 2°, 2002, pp. 274 e 277, 58, 70,68. Pierino Bello, Dizionario del dialetto di Pietraroja, Pietraroja, Pro loco, 2005, pp. 29, 177 , 272, 277. da quando, perché, come? Vediamo! E al riguardo mi pare convenga partire da lontano. Nicola Rotondi, colto arcidiacono di Cerreto, ha sostenuto, in un suo manoscritto del XIX secolo, poi dato alle stampe, che la pastorizia, procedendo da Abele, secondo figlio di Adamo primo uomo, era passata ai patriarchi nati da Set, il terzo figlio, e da quelli ad ogni popolo della terra. In più, nella Bibbia non poco e già nella Genesi, e in altre opere, si legge di piccolo bestiame, di greggi, di pastori e, altresì, di sacerdoti e di faraoni; si legge di bastoni, di mazze, di verghe, di vincastri e di bacoli, con funzione di difesa, di lavoro, di protezione e guida del gregge, di armi e d’insegna di comando e dignità.4Cfr. Nicola Rotondi, Memorie storiche di Cerreto Sannita, ms., 1869 – 1875, a c.d. Antonello Santagata, San Salvatore Telesino, Fiori di Zucca Ed., 3, 2019 e 2023, 1, p. 163. La Sacra Bibbia, Roma, CEI, 1974, pass; Nicolas Grimal, L’antico Egitto, I, Milano, Corriere della Sera, 2004, pp. 5, 24, 25, 28-30. B. Migliorini, 1965, pp. 222,799-800,1268. Versione di episodio significante rammenta che Mosè, menando al pascolo le pecore del suocero, sacerdote in Palestina, giunse sull’ Oreb, il Monte di Dio, gli si rivelò il Signore in mezzo ad una fiamma e gli disse: “Io ti mando dal faraone, fai uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti”; Mosè rispose che non l’avrebbero creduto né ascoltato; allora il Signore, in collera contro Mosè, disse: “Che hai in mano?” Mosè rispose: “Un bastone”; Dio riprese: “Terrai in mano questo bastone con il quale compirai prodigi”; Mosè obbedì e “col bastone di Dio” fece prodigi.mfn]Cfr. La Sacra Bibbia, 1974, Esodo, III: 1-2, 4, 6 e 10; IV: 1-4, 17 e 20; pass.[/mfn] Altra versione eloquente rievoca che Davide, pecoraio da ragazzo e poi re d’Israele, inneggiò al Signore che, suo “pastore”, lo forniva di tutto: “su pascoli erbosi” lo faceva riposare; “ad acque tranquille” lo conduceva; lo rinfrancava; lo guidava “per il giusto sentiero”; nel cammino “in una valle oscura” lo liberava dal timore d’ogni male, perché era con lui; il suo “vincastro” e il suo “bastone” gli davano sicurezza”.5Cfr. La Sacra Bibbia, 1974, Primo libro di Samuele, capp. 16 e 17; Secondo libro di Samuele, cap. 3. Salmi, Salmo 22, diDavide, 1- 6. Il bastone di Dio– e il vincastro indicavano: l’uno il potere divino e l’altro quello pastorale.

Divinità e sovrani apparivano, nell’arte figurativa, col bastone, simbolo di potere, creduto talismano, di varia prominenza e con vertice modellato o ad uncino, o curvo, o arrotondato, o piriforme. Genti che affacciavano sul Mar Mediterraneo e a confine, utilizzavano, di consueto, il menzionato attrezzo.6Tanto, da immagini di antichi bastoni. Cfr. anche AA.VV. Dalla preistoria all’antico Egitto, Roma, La biblioteca di Repubblica, 2004, figg. a pp. 226, 456, 560, 664, 670. Nicolas Grimal, 2004, figg. 5, 43, 44, 52, 54. AA. DD., a c.d., Il libro dei morti EE. DD. pass. R. Di Lello, Esempi in foto n.1 nel testo. Per le genti del Sannio, agricoltori e pastori, l’allevamento ovino era più importante di altre industrie, a motivo della necessaria produzione di lana, latte e derivati, talché, col sopraggiungere del freddo invernale, i pecorai “percorrevano con i loro greggi lunghe distanze per raggiungere zone di pascolo in pianura”7E.T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti, Torino, Giulio Einaudi, 1985, pass. e pp. 55,56,72-74,79. Per insediamenti sul Matese, cfr. Id., ibid., pass. Nicola Rotondi, 1869,2019, I, pp 163-168 AA.VV., Sepino Archeologia e continuità, Campobasso, Ed. Enne, 1979, pp. 5-31. AA.VV., Sannio Pentri e Frentani dal VI al I sec. A.C. Roma, De Luca Ed., 1980, pass. Nicola Mancini, Raviscanina, Piedimonte Matese, ikona, 1998, pp.5-21. Alberico Boiano, La ricchezza delle pecore, Napoli, Guida Editori, 2022, pp. 19-24. Lorenzo Morone, Dall’Urtz al santuario italico di Cerreto Sannita, dalle case sparse di Vallantico a Telesia, in “Almanacco”, Telese, ISST, 08/02/2025. Id., La bussola di Caia Borsa, in “Almanacco”, Telese, ISST, 22/03/2025. e praticare scambi economici e culturali con i residenti. Circa i bastoni e in mancanza di reperti allo stato della ricerca, ho pensato che i pastori del Matese abbiano rifinito negli aspetti soliti le cuspidi di pertiche,8Da immagini di antichi bastoni e da: AA.VV., 2004, figg. a pp. 226, 456, 560, 664, 670, Nicolas Grimal, 2004, figg. 5, 43, 44, 52, 54. AA. DD. a c.d., Il libro dei morti, EE. DD., pass. quando non semplici e robuste di natura. Nel Medioevo, la pastorizia, in più larga misura l’ovina, fu pratica fondamentale in special modo nelle zone rurali; sul Matese, d’altro canto, al di là dei miglioramenti vi furono momenti di crisi, pure a cagione di danni conseguiti a transumanza.9Cfr. Nicola Rotondi, 1869,2019, I, pp. 163-168. AA.VV., 1979, p. 31. AA.VV., Le vie della transumanza, Foggia, Leone, 1984, pass. Il bastone, indispensabile e ordinario, conservò lunghezza e cima nelle forme descritte e il “vingiastro” diventò – potremmo dire –, più menzionato da quando Dante Alighieri poetò:
Lo villanello a cui la roba manca,
si leva, e guarda, e vede la campagna
biancheggiar tutta;
poi ritorna e,
veggendo ‘l mondo aver cambiata faccia
in poco d’ora, e prende suo vincastro
e fuor le pecorelle a pascer caccia”.10Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, XXIV, 7-15.
Il bacolo, rimase strumento ecclesiastico, come dimostra l’utensile ad apice arrotolato di Antonio Moretta, dal 1458 al 1482 vescovo della diocesi di Alife.11Cfr. AA VV, Alife, Ivi, Amministrazione Comunale, s.d., pp. 22-23 e lastra tombale del vescovo Moreta.

Nell’Evo Moderno, in Cerreto e “paesi vicini” la “industria delle pecore” è stata florida, di migliaia di capi, però a non pochi venne in mente il detto: “Chi ha animali, or ride, or piange”, quando, nel 1676, “per l’usato malore messosi nelle lor pecore” i proprietari “videro tornare quasi il niente” del molto bestiame mandato a transumare in Puglia;12Nicola Rotondi, 1869,2019, I, pp. 163-168. e nella “vecchia e nuova Cerreto”, prima e dopo l’orrendo terremoto del 1688 un detto ha sostenuto: “Chi nun tene pecure, nun perde” –Chi non possiede pecore non perde mai–;13Domenico Franco, La pastorizia e il commercio della lana nella vecchia e nuova Cerreto, in “Samnium”, Napoli, Istituto della Stampa, XXXVIII, 1965, III-IV e XXXIX,1966, I-II. Pasqualina Di Lello Manzelli, Alcune tradizioni popolari in Pietraroia, “Annuario 1975”, Napoli, Laurenziana, 1975,pp. 84-86, 90-91, 95, in 82-98. R Di Lello, 1979, p.72. il bastone, comunque, ha trovato sempre utilizzo, nelle forme consuete, anche se qualche volta per branchi esigui di ovini. Nel ‘700, il sacro pastorale ad estremità inclinata, lo si è potuto ammirare tenuto da un vescovo effigiato a Cerreto;14Cfr. Nicola Vigliotti, Renato Pescitelli, La ceramica di Cerreto Sannita e San Lorenzello, San Lorenzello, ECSG, 2007, p. 88, “Acquasantiera, decorata a rilievo con Vescovo”. nei secoli successivi, il bacolo, con sommità ricurva, verrà ancora portato, in solenni occasioni e in segno di dignità, dal vescovo,15Cfr. B. Migliorini, 1965, p. 982. dal cardinale e dal papa, pastori del gregge cattolico.

Ai giorni nostri e in relazione a pastorizia e attività connesse, non mancano informazioni che toccano il secolo scorso e il presente. A fine estate del 1903 Gabriele D’Annunzio ha composto in versi che a “settembre”, essendo “tempo di migrare” in transumanza, i pastori “lascian gli stazzi” di montagna, e “scendono all’Adriatico”, perciò rinnovano la “verga d’avellano” e, guidando il gregge, “vanno pel tratturo antico al piano […] su le vestigia degli antichi padri”.16Gabriele D’Annunzio, I pastori, 1903, 1-13. Per il bastone tradizionale, è opportuno anticipare che, col trascorrer del tempo, sul Matese s’è cimentato, oltre al pecoraio, qualche contadino, tale da sempre o non più pastore. Negli anni Settanta, zi’ Gabriele Bello, domiciliato a Pietraroja in località Ariola, mi fece dono di due “angini”, da lui manufatti da “ullana” – nocciola, avellano –, e da “vrignale” – corniolo –, ciascuno con inciso, sul vertice a becco, un suggestivo volto d’uomo o di donna; li riporto qui in foto, insieme ad un terzo di anonimo artefice.17Vedi R. Di Lello, 1979, fig. 19.
Alquanto dopo vidi in Pietraroja, da Lucia Falcigno, gli esemplari collezionati dal genitore Domenico. Egli aveva scritto tre preziosi articoli su pastorizia, produzione e transumanza, e vi fa vedere dieci relative immagini, una delle quali, qui a capo di titolo, propone, munito di uncino, un “Pastore con cane e gregge sulla Civita”, località a monte del paese; altra, di un calendario del 2015, mostra, qui nel dettaglio, un pastore che tiene con la destra un artistico uncino con volto,18Cfr. Domenico Falcigno, La pastorizia: ieri ed oggi, in “Storia di tutti i giorni vecchi discorsi”, Pietraroia, Pro Loco-Comune,2005, pp. 13-15; Id., Il formaggio pecorino, “ibid.”, 2006, pp. 21-24; Id., Pastorizia e transumanza, con foto, “ibid.”,2011, pp. 2-7. Calendario, Pietraroja che fu. Antichi mestieri, con foto, 2015”, Pietraroja, Pro Loco. opera, è probabile, del nominato Gabriele Bello.

Il 20 ottobre 2017, nel castagneto in località Filette, a Pietraroja, m’imbattei in Antonio Cusanelli che, molto avanti negli anni e seduto davanti casa, filava spago; lo fotografai e mi confidò d’essere stato custode di pecore e di agnelli da quando aveva nove anni, al pari di coetanei, ed uno degli ultimi, nel 1970-‘80, a far transumanza in Puglia e d’avervi imparato, durante le soste, a confezionare “cisti re vinci” – cesti di vimini –, “funi e bastuni”.19Ref. A. Cusanelli, Pietraroja, 20 ottobre 2017, ore 12.30. Il 15 aprile 2023, da Anna Luisa Bello, di Pietraroja, ho ricevuto l’immagine di quattro “bastuni”, due con uncino legato al tronco in attesa della stagionatura; suo nonno, Antonio Cusanelli, domiciliato in località Filette, li aveva tratti da germogli di castagno, flessibili eppure resistenti, per uso personale e per doni eventuali.20A.L. Bello, 15, 4, 2023, ore 14,32 e tel. pass.

Il 10 marzo 2025, sempre Anna L. Bello mi ha inviato due foto dei bastoni collezionati, datele da Lucia Falcigno; una di esse mette in evidenza una “mazzocca”, portata a compimento con testa grossa e tondeggiante, purtroppo corrosa, e una forma, approssimativa, forse di “pirocca”.21A.L. Bello, ref. con foto, per iPhone del 10,3, 2025, ore 17,12.
Dal 4 al 6 luglio 2025, ho trovato, da Nicola De Carlo, da Domenico Varrone e da Giuseppe Iamartino, in Pietraroja, tre rare “pirocche”, di rispettive misure decrescenti e dal De Carlo mi ha sorpreso un bastone incompleto; ho fotografato tutto il materiale e osservando l’arnese incompiuto ho dedotto che il pastore, eliminati i rami e parte del nodo in comune, somigliante a collo e testa bovina, avrebbe potuto ricavare il culmine di “pirocca”. E non è tutto: Giovanni Mannato, di Pietrarojia, mi ha reso noto d’aver “fatto una pirocca con nodo del vrignale e un vingiastro con salice”.22G. Mannato, tel, 0824 868044, ref. in Pietraroja, Piazza Municipio, 6-7-2025, ore 12.39.

Infine, in appunti sulla matesina cultura agricola e pastorale, messi insieme nel corso di un’indagine sul campo, integrati con testi e foto e quindi editati, ma soltanto in parte,23Cfr. R. Di Lello, 1979, cit. Id. Aspetti dell’arte agro-pastorale nel Beneventano (Esperienze e prospettive), “Rivista Storica Del Sannio”, Benevento, De Toma, I, 2, 1983, pp. 43-52. ho riletto che, “per tradizione secolare”, il pastore di Pietraroja, così come quello di altri paesi dell’area matesina, costruiva “da sé” con legno o di nocciola, o di corniolo, o di castagno, o di vinco, bastoni ”quanto la propria altezza, o più o meno di poco”; ne arrotondava la cuspide, oppure l’incurvava e la teneva legata qualche tempo per la “stagionatura”, se di castagno, altrimenti e più di frequente, se di nocciola o di corniolo, integrava più agevolmente la biforcazione di due rami contigui mozzandola, accorciandone uno e manipolandolo “a becco”. Il bastone, ripeto, in generico dialetto “bastònu” e nello specifico “angìnu, piròcca, vingiàstru e mazzòcca”, era, cosi come altri oggetti, un mezzo di lavoro personale da rispondere a esigenze e caratteristiche individuali e, perciò, da esser “fatto con le sue stesse mani dal pecoraio” e in giusta misura. Perché era di legno, lungo e con estremità elaborata? Perché risultava: garantito dalla tradizione, economico, di abituale e semplice fattura, resistente, di facile e comoda presa, leggero e adeguato al molteplice impiego, quale? Oltretutto: il sostegno della persona, nella deambulazione, specialmente nei lunghi tragitti; il “menare allineate le pecore fuori,” in transumanza, in pascoli verdi e verso limpide acque abbondanti; il raggrupparle all’ombra nelle ore calde; “l’appoggio e il riposo, sempre all’erta” nel sorvegliarle in sosta, tenendolo puntato a terra, col palmo delle mani “sopra il tunno” – sul tondo –, e col mento sul dorso delle stesse; il difendere “la mansueta pecorella” da bestie aggressive, l’ “acchiappare” e trarre a sé quella fugace da mungere o l’agnello caduto in un corso d’acqua o in un fosso; il “trattenere al collare il cane” che s’avventava; il “portare a spalla una mappata” – un fagotto –, il tirar giù dall’albero qualche rametto con della frutta. Ed è probabile che il pastore, pur se inconsapevolmente, abbia talvolta valutato miracoli i risultati positivi ottenuti col bastone; non solo: forse per questo e per evidenziare la propria importanza socio-economica e la conseguente autorità, nonché la capacità artistica, nei momenti di riposo abbia impreziosito, con intagli, l’insostituibile, inseparabile, simbolico compagno di lavoro e di sopravvivenza e tanto non mai per lucro, ma anche al fine di farne eventuale dono, sincero ed eloquente.
In conclusione, oso pensare che perfino un umile oggetto possa costituire motivo e argomento di storia; o no?
____________________
Note:
[1] Per Cerreto e Pietraroja, ad esempio, ho appreso di manufatti architettonici, commemorativi, apotropaici e scaramantici; cfr. R. Di Lello, in “Almanacco”, Istituto Storico Sannio Telesino (ISST) 2020 (1), 2021 (3), 2024 (1), passim.
[2] Per il territorio, cfr. Dante B. Marrocco, Piedimonte Matese, ivi, ASMV, 1980, cap. XXVI, Il Matese, pp. 445-477.
[3] Per i detti termini in vernacolo ed altri, cfr. Bruno Migliorini, Vocabolario della lingua Italiana, Torino, G.B. Paravia & C., 1965, pp.139, 222, 799-800,1547,1602-1603. CC.VV., Nuovissimo Dardano. Dizionario della lingua italiana, Roma, Curcio, 1982, pp. 1829, 2335-2336. F. Galiani, Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, Napoli, Porcelli, tomo primo, 1783, p. 17. Raffaele Andreoli, Vocabolario napoletano italiano, Torino, 1887, Pozzuoli-Napoli, De Marco, 1993, pp. 26, 293. R. Di Lello, Aspetti della cultura agricola e pastorale sul Matese, “Annuario 1979”, Piedimonte Matese, Associazione Storica del Medio Volturno, 1979, p74 in 64-85. AA.VV., Guardiaregia, a c.d. Pietro Vecchiarelli, Campobasso, Lampo Ed., 1982, pp. 95 e vid. pp. 98 e 129. Elena Cofrancesco, La parlata cerretese ‘L c’rratèen, Cerreto Sannita, Associazione Socio Culturale Cerretese, 2°, 2002, pp. 274 e 277, 58, 70,68. Pierino Bello, Dizionario del dialetto di Pietraroja, Pietraroja, Pro loco, 2005, pp. 29, 177 , 272, 277.
[4] Cfr. Nicola Rotondi, Memorie storiche di Cerreto Sannita, ms., 1869 – 1875, a c.d. Antonello Santagata, San Salvatore Telesino, Fiori di Zucca Ed., 3, 2019 e 2023, 1, p. 163. La Sacra Bibbia, Roma, CEI, 1974, pass; Nicolas Grimal, L’antico Egitto, I, Milano, Corriere della Sera, 2004, pp. 5, 24, 25, 28-30. B. Migliorini, 1965, pp. 222,799-800,1268.
[5] Cfr. La Sacra Bibbia, 1974, Esodo, III: 1-2, 4, 6 e 10; IV: 1-4, 17 e 20; pass.
[6] Cfr. La Sacra Bibbia, 1974, Primo libro di Samuele, capp. 16 e 17; Secondo libro di Samuele, cap. 3. Salmi, Salmo 22, di Davide, 1- 6. Il bastone di Dio– e il vincastro indicavano: l’uno il potere divino e l’altro quello pastorale.
[7] Tanto, da immagini di antichi bastoni. Cfr. anche AA.VV. Dalla preistoria all’antico Egitto, Roma, La biblioteca di Repubblica, 2004, figg. a pp. 226, 456, 560, 664, 670. Nicolas Grimal, 2004, figg. 5, 43, 44, 52, 54. AA. DD., a c.d., Il libro dei morti EE. DD. pass. R. Di Lello, Esempi in foto n.1 nel testo.
[8] E.T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti, Torino, Giulio Einaudi, 1985, pass. e pp. 55,56,72-74,79. Per insediamenti sul Matese, cfr. Id., ibid., pass. Nicola Rotondi, 1869,2019, I, pp 163-168 AA.VV., Sepino Archeologia e continuità, Campobasso, Ed. Enne, 1979, pp. 5-31. AA.VV., Sannio Pentri e Frentani dal VI al I sec. A.C. Roma, De Luca Ed., 1980, pass. Nicola Mancini, Raviscanina, Piedimonte Matese, ikona, 1998, pp.5-21. Alberico Boiano, La ricchezza delle pecore, Napoli, Guida Editori, 2022, pp. 19-24. Lorenzo Morone, Dall’Urtz al santuario italico di Cerreto Sannita, dalle case sparse di Vallantico a Telesia, in “Almanacco”, Telese, ISST, 08/02/2025. Id., La bussola di Caia Borsa, in “Almanacco”, Telese, ISST, 22/03/2025.
[9] Da immagini di antichi bastoni e da: AA.VV., 2004, figg. a pp. 226, 456, 560, 664, 670, Nicolas Grimal, 2004, figg. 5, 43, 44, 52, 54. AA. DD. a c.d., Il libro dei morti, EE. DD., pass.
[10] Cfr. Nicola Rotondi, 1869,2019, I, pp. 163-168. AA.VV., 1979, p. 31. AA.VV., Le vie della transumanza, Foggia, Leone, 1984, pass.
[11] Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, XXIV, 7-15.
[12] Cfr. AA VV, Alife, Ivi, Amministrazione Comunale, s.d., pp. 22-23 e lastra tombale del vescovo Moreta. [13] Nicola Rotondi, 1869,2019, I, pp. 163-168.
[14] Domenico Franco, La pastorizia e il commercio della lana nella vecchia e nuova Cerreto, in “Samnium”, Napoli, Istituto della Stampa, XXXVIII, 1965, III-IV e XXXIX,1966, I-II. Pasqualina Di Lello Manzelli, Alcune tradizioni popolari in Pietraroia, “Annuario 1975”, Napoli, Laurenziana, 1975,pp. 84-86, 90-91, 95, in 82-98. R Di Lello, 1979, p.72.
[15] Cfr. Nicola Vigliotti, Renato Pescitelli, La ceramica di Cerreto Sannita e San Lorenzello, San Lorenzello, ECSG, 2007, p. 88, “Acquasantiera, decorata a rilievo con Vescovo”.
[16] Cfr. B. Migliorini, 1965, p. 982.
[17] Gabriele D’Annunzio, I pastori, 1903, 1-13.
[18] Vedi R. Di Lello, 1979, fig. 19.
[19] Cfr. Domenico Falcigno, La pastorizia: ieri ed oggi, in “Storia di tutti i giorni vecchi discorsi”, Pietraroia, Pro Loco-Comune,2005, pp. 13-15; Id., Il formaggio pecorino, “ibid.”, 2006, pp. 21-24; Id., Pastorizia e transumanza, con foto, “ibid.”,2011, pp. 2-7. Calendario, Pietraroja che fu. Antichi mestieri, con foto, 2015”, Pietraroja, Pro Loco.
[20] Ref. A. Cusanelli, Pietraroja, 20 ottobre 2017, ore 12.30.
[21] A.L. Bello, 15, 4, 2023, ore 14,32 e tel. pass.
[22] A.L. Bello, ref. con foto, per iPhone del 10,3, 2025, ore 17,12.
[23] G. Mannato, tel, 0824 868044, ref. in Pietraroja, Piazza Municipio, 6-7-2025, ore 12.39. 24– Cfr. R. Di Lello, 1979, cit. Id. Aspetti dell’arte agro-pastorale nel Beneventano (Esperienze e prospettive), “Rivista Storica.

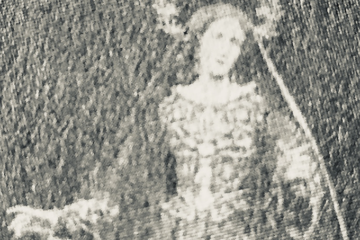
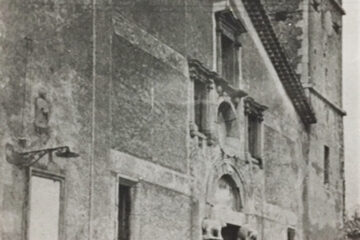
 Antonella Selvaggio
Antonella Selvaggio Archeologa classica. Lavora presso l’Università del Salento.
Archeologa classica. Lavora presso l’Università del Salento. Medico e scrittore. Ha all’attivo numerose collaborazioni con riviste di carattere storico. Ha pubblicato una Vita di San Leucio, il libro: “Da Casale a Comune” e la Storia della Parrocchiale Santa Maria Assunta di San Salvatore Telesino. Ha partecipato all’Antologia “Dieci Medici Raccontano”, che ha ottenuto il “Premio Rufolo 2019”. Premio Olmo 2009 per il romanzo storico «L’ultima notte di Bedò», è anche autore di alcuni saggi sulla Storia della Medicina tra cui uno studio sulla Depressione dal titolo «Il potere misterioso della bile nera, breve storia della depressione da Ippocrate a Charlie Brown». Nel 2024 ha pubblicato “Fu la peste” e “Islam a Telesia” per ABE Editore Napoli. Fondatore e Direttore Editoriale della Casa Editrice Fioridizucca.
Medico e scrittore. Ha all’attivo numerose collaborazioni con riviste di carattere storico. Ha pubblicato una Vita di San Leucio, il libro: “Da Casale a Comune” e la Storia della Parrocchiale Santa Maria Assunta di San Salvatore Telesino. Ha partecipato all’Antologia “Dieci Medici Raccontano”, che ha ottenuto il “Premio Rufolo 2019”. Premio Olmo 2009 per il romanzo storico «L’ultima notte di Bedò», è anche autore di alcuni saggi sulla Storia della Medicina tra cui uno studio sulla Depressione dal titolo «Il potere misterioso della bile nera, breve storia della depressione da Ippocrate a Charlie Brown». Nel 2024 ha pubblicato “Fu la peste” e “Islam a Telesia” per ABE Editore Napoli. Fondatore e Direttore Editoriale della Casa Editrice Fioridizucca.


 Laurea magistrale in Lettere. Docente a Prato. Ha approfondito gli eventi storici che portarono alla “Marcia della fame” del 1957 nei comuni del Valfortore sannita. Ha scritto il “Catasto Onciario della Terra di San Salvatore”.
Laurea magistrale in Lettere. Docente a Prato. Ha approfondito gli eventi storici che portarono alla “Marcia della fame” del 1957 nei comuni del Valfortore sannita. Ha scritto il “Catasto Onciario della Terra di San Salvatore”.

 Scrittore, poeta e divulgatore culturale. Medico di continuità assistenziale. Autore di diversi saggi storici e racconti. Ha partecipato all’antologia “Dieci Medici Raccontano”. Fondatore del Premio Nazionale Olmo che tutti gli anni si svolge in Raviscanina (Ce).
Scrittore, poeta e divulgatore culturale. Medico di continuità assistenziale. Autore di diversi saggi storici e racconti. Ha partecipato all’antologia “Dieci Medici Raccontano”. Fondatore del Premio Nazionale Olmo che tutti gli anni si svolge in Raviscanina (Ce). Dottore in Lettere. all’Università di Salerno, indirizzo “storico medievale”. Si è poi laureata in Scienze della Formazione primaria all’Ateneo di Campobasso. Studiosa della storia della sua città. Lettrice instancabile di autori italiani e stranieri, si occupa della formazione di piccoli lettori e poeti. È insegnante nella Scuola Primaria da quindici anni. Ha sperimentato innovative metodologie di approccio alla lettura utilizzando le nuove tecnologie che hanno portato alla pubblicazione di una ricerca dal titolo: TIC e DSA. Riflessioni ed esperienze sulle nuove frontiere della pedagogia speciale, Ed. EriksonLive. La storia locale e la ricerca accurata le ha permesso di pubblicare anche un Saggio in storia medievale sull’assetto urbano e riorganizzazione del territorio della Benevento nei sec. XI e XII. Animatore culturale, scrive poesie per fermare in foto-scritte, attimi di vita.
Dottore in Lettere. all’Università di Salerno, indirizzo “storico medievale”. Si è poi laureata in Scienze della Formazione primaria all’Ateneo di Campobasso. Studiosa della storia della sua città. Lettrice instancabile di autori italiani e stranieri, si occupa della formazione di piccoli lettori e poeti. È insegnante nella Scuola Primaria da quindici anni. Ha sperimentato innovative metodologie di approccio alla lettura utilizzando le nuove tecnologie che hanno portato alla pubblicazione di una ricerca dal titolo: TIC e DSA. Riflessioni ed esperienze sulle nuove frontiere della pedagogia speciale, Ed. EriksonLive. La storia locale e la ricerca accurata le ha permesso di pubblicare anche un Saggio in storia medievale sull’assetto urbano e riorganizzazione del territorio della Benevento nei sec. XI e XII. Animatore culturale, scrive poesie per fermare in foto-scritte, attimi di vita. Lorenzo Piombo, medico psichiatra, dirigente del Dipartimento Salute Mentale della ASL di Benevento. Ricercatore e studioso di storia. Vive e opera a Morcone.
Lorenzo Piombo, medico psichiatra, dirigente del Dipartimento Salute Mentale della ASL di Benevento. Ricercatore e studioso di storia. Vive e opera a Morcone. Avvocato. Patrocinante in Cassazione. Scrittore di Storia Locale. Opera a Guardia Sanframondi.
Avvocato. Patrocinante in Cassazione. Scrittore di Storia Locale. Opera a Guardia Sanframondi.
 Architetto e docente. Appassionato cultore di Storia Locale in Cerreto Sannita, città in cui vive. Ha come campi di interesse gli insediamenti abitativi sanniti. Collabora con il Blog dell’Istituto Storico del Sannio di cui è socio fondatore. È autore del saggio “Cominium Ocritum e le forche caudine: una storia
Architetto e docente. Appassionato cultore di Storia Locale in Cerreto Sannita, città in cui vive. Ha come campi di interesse gli insediamenti abitativi sanniti. Collabora con il Blog dell’Istituto Storico del Sannio di cui è socio fondatore. È autore del saggio “Cominium Ocritum e le forche caudine: una storia  Studioso del ‘700 napoletano e dell’epopea di Federico II ha approfondito in modo particolare le influenza arabe sull’architettura napoletana. Studioso di suffisso e di religioni orientali.
Studioso del ‘700 napoletano e dell’epopea di Federico II ha approfondito in modo particolare le influenza arabe sull’architettura napoletana. Studioso di suffisso e di religioni orientali. Medico del Lavoro. Regista teatrale. Giornalista pubblicista. Fondatore di “Byblos”, la biblioteca del Sannio. Scrittore e divulgatore della storia e dei personaggi del Sannio, ha pubblicato “A tavola nel Sannio”, una guida ai ristoranti della provincia di Benevento; “Dietro la Leggenda” (2016), una raccolta di racconti ispirati a fiabe e a leggende del Sannio. Nel 2017 ha pubblicato “Samnes”, un romanzo storico sull’epopea sannita. Ha curato la trascrizione del manoscritto e la stampa dei tre volumi delle “Memorie storiche di Cerreto Sannita per Arcidiacono Nicola Rotondi”. Nel 2019 ha pubblicato “Guida alla Valle Telesina e al Sannio”. Ha pubblicato “Il delitto del pozzo dei pazzi”, un medical-thriller ambientato nel primo ‘900 nell’ospedale degli Incurabili di Napoli. È autore della “Storia di Cerreto dalla preistoria alla seconda guerra mondiale (2022) e di “Fiabe e Favole in cerretese”, edito da Fioridizucca. (2023).
Medico del Lavoro. Regista teatrale. Giornalista pubblicista. Fondatore di “Byblos”, la biblioteca del Sannio. Scrittore e divulgatore della storia e dei personaggi del Sannio, ha pubblicato “A tavola nel Sannio”, una guida ai ristoranti della provincia di Benevento; “Dietro la Leggenda” (2016), una raccolta di racconti ispirati a fiabe e a leggende del Sannio. Nel 2017 ha pubblicato “Samnes”, un romanzo storico sull’epopea sannita. Ha curato la trascrizione del manoscritto e la stampa dei tre volumi delle “Memorie storiche di Cerreto Sannita per Arcidiacono Nicola Rotondi”. Nel 2019 ha pubblicato “Guida alla Valle Telesina e al Sannio”. Ha pubblicato “Il delitto del pozzo dei pazzi”, un medical-thriller ambientato nel primo ‘900 nell’ospedale degli Incurabili di Napoli. È autore della “Storia di Cerreto dalla preistoria alla seconda guerra mondiale (2022) e di “Fiabe e Favole in cerretese”, edito da Fioridizucca. (2023). È nato e vive a Castelvenere. Già docente di materie letterarie nella scuola statale, ha pubblicato diverse raccolte di liriche, pagine di ricerca letteraria, studi relativi alla cultura popolare. È presente in antologie, dizionari bio-bibliografici e testi scolastici. Appassionato si storia e di tradizioni locali, è membro di associazioni culturali nazionali. I suoi versi hanno ricevuto giudizi positivi da parte della critica e in concorsi letterari si è classificato ai primi posti.
È nato e vive a Castelvenere. Già docente di materie letterarie nella scuola statale, ha pubblicato diverse raccolte di liriche, pagine di ricerca letteraria, studi relativi alla cultura popolare. È presente in antologie, dizionari bio-bibliografici e testi scolastici. Appassionato si storia e di tradizioni locali, è membro di associazioni culturali nazionali. I suoi versi hanno ricevuto giudizi positivi da parte della critica e in concorsi letterari si è classificato ai primi posti.
 Architetto, libero professionista. Si occupa di progettazione architettonica, interior design e aspetti legati all’architettura del paesaggio. Dal 2021 è Consigliere dell’ordine degli Architetti della Provincia di Benevento. Ha partecipato a Mostre sul restauro architettonico e a numerose iniziative riguardanti la promozione territoriale.
Architetto, libero professionista. Si occupa di progettazione architettonica, interior design e aspetti legati all’architettura del paesaggio. Dal 2021 è Consigliere dell’ordine degli Architetti della Provincia di Benevento. Ha partecipato a Mostre sul restauro architettonico e a numerose iniziative riguardanti la promozione territoriale.
 Insegnante, vive a Caiazzo. È Presidente del’Associazione Storica del Caiatino.
Insegnante, vive a Caiazzo. È Presidente del’Associazione Storica del Caiatino. Cultore di storia locale e delle tradizioni del suo paese. Autore del saggio “Notizie storiche ed urbanistiche di Cerreto antica” in cui ha ricostruito l’antico borgo distrutto dal terremoto del 1688.
Cultore di storia locale e delle tradizioni del suo paese. Autore del saggio “Notizie storiche ed urbanistiche di Cerreto antica” in cui ha ricostruito l’antico borgo distrutto dal terremoto del 1688. Originario di Castelvenere. Già dipendente del Miur ora in pensione. Appassionato di Storia locale ed animatore di gruppi per la diffusione della lingua e delle tradizioni di Castelvenere.
Originario di Castelvenere. Già dipendente del Miur ora in pensione. Appassionato di Storia locale ed animatore di gruppi per la diffusione della lingua e delle tradizioni di Castelvenere.
 Nato a Napoli e residente in Piedimonte Matese. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli e successiva specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Modena è stato aiuto chirurgo presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese e, dal maggio 1990, primario del reparto di Pronto Soccorso. Attualmente è pensionato. Dal 1° giugno 1978 è socio corrispondente dell’Associazione Culturale Italo Ispanica “C. Colombo – Madrid”. Negli anni 1972-73, in collaborazione con altri, ha pubblicato alcuni articoli specialistici su riviste mediche. Cultore di storia e tradizioni locali ha pubblicato studi su vari Annuari e collane dell’Associazione Storica del Medio Volturno (sodalizio del quale oltre che socio è stato in passato anche componente del consiglio direttivo) ed in altre riviste e quotidiani regionali.
Nato a Napoli e residente in Piedimonte Matese. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli e successiva specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Modena è stato aiuto chirurgo presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese e, dal maggio 1990, primario del reparto di Pronto Soccorso. Attualmente è pensionato. Dal 1° giugno 1978 è socio corrispondente dell’Associazione Culturale Italo Ispanica “C. Colombo – Madrid”. Negli anni 1972-73, in collaborazione con altri, ha pubblicato alcuni articoli specialistici su riviste mediche. Cultore di storia e tradizioni locali ha pubblicato studi su vari Annuari e collane dell’Associazione Storica del Medio Volturno (sodalizio del quale oltre che socio è stato in passato anche componente del consiglio direttivo) ed in altre riviste e quotidiani regionali. Musicista. Maestro di clarinetto ed orchestrale. Studioso di storia della filosofia e del ‘700 napoletano. Esperto simbolista e autore di testi esoterico/filosofici.
Musicista. Maestro di clarinetto ed orchestrale. Studioso di storia della filosofia e del ‘700 napoletano. Esperto simbolista e autore di testi esoterico/filosofici. Nato a Telese Terme ma originario di Amorosi è stato allievo del filosofo Massimo Achille Bonfantini. Laureato in Semiotica e Filosofia del Linguaggio presso l’Università l’Orientale di Napoli. Dedica le sue ricerche prevalentemente allo studio della filosofia e della psicologia dell’inconscio, come dei nuovi percorsi conoscitivi applicati alle neuroscienze. Ha pubblicato Cento petali e una rosa. Semiosi di un romanzo storico (Natan, 2016), Filosofia hegeliana e religione. Osservazioni su Sebastiano Maturi (Natan, 2017) e, recentemente, il saggio dal titolo: Nel gioco di un’incerta reciprocità: Gregory Bateson e la teoria del “doppio legame” (Ediz. Del Faro, 2020).
Nato a Telese Terme ma originario di Amorosi è stato allievo del filosofo Massimo Achille Bonfantini. Laureato in Semiotica e Filosofia del Linguaggio presso l’Università l’Orientale di Napoli. Dedica le sue ricerche prevalentemente allo studio della filosofia e della psicologia dell’inconscio, come dei nuovi percorsi conoscitivi applicati alle neuroscienze. Ha pubblicato Cento petali e una rosa. Semiosi di un romanzo storico (Natan, 2016), Filosofia hegeliana e religione. Osservazioni su Sebastiano Maturi (Natan, 2017) e, recentemente, il saggio dal titolo: Nel gioco di un’incerta reciprocità: Gregory Bateson e la teoria del “doppio legame” (Ediz. Del Faro, 2020). Nato a Ponte, dove risiede. Dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato. Cultore di storia locale con particolare attenzione al periodo medievale. Ha pubblicato “Ponte tra Cronaca e Storia”, “Domenico Ocone, quarant’anni di storia pontese…”, “Le Vie di Ponte tra Storia e Leggenda”. Collabora con varie associazioni culturali.
Nato a Ponte, dove risiede. Dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato. Cultore di storia locale con particolare attenzione al periodo medievale. Ha pubblicato “Ponte tra Cronaca e Storia”, “Domenico Ocone, quarant’anni di storia pontese…”, “Le Vie di Ponte tra Storia e Leggenda”. Collabora con varie associazioni culturali. Farmacista. Dopo la laurea ha conseguito un master biennale e un corso di perfezionamento, approfondendo le conoscenze in ambito fitoterapico, micoterapico e nutraceutico, con la pubblicazione del lavoro di tesi sulla rivista di divulgazione scientifica di medicina naturale ‘Scienza Natura’ del Prof. Ivo Bianchi. Attivo nel sociale, è membro del Rotary Club Valle Telesina ed è amante dello sport e della natura. Innamorato del proprio territorio, ha iniziato a coltivare l’interesse per la storia locale.
Farmacista. Dopo la laurea ha conseguito un master biennale e un corso di perfezionamento, approfondendo le conoscenze in ambito fitoterapico, micoterapico e nutraceutico, con la pubblicazione del lavoro di tesi sulla rivista di divulgazione scientifica di medicina naturale ‘Scienza Natura’ del Prof. Ivo Bianchi. Attivo nel sociale, è membro del Rotary Club Valle Telesina ed è amante dello sport e della natura. Innamorato del proprio territorio, ha iniziato a coltivare l’interesse per la storia locale.



 Presidente dell’Associazione culturale “La Biblioteca del Sannio”, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con una tesi sulla metadatazione della cartografia storica. Giornalista e direttore di Canale Sassuolo. Già docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola e Global History, presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo vanvitelliano, è attualmente tutor di Storia Contemporanea e Storia dei Partiti e Movimenti politici.
Presidente dell’Associazione culturale “La Biblioteca del Sannio”, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con una tesi sulla metadatazione della cartografia storica. Giornalista e direttore di Canale Sassuolo. Già docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola e Global History, presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo vanvitelliano, è attualmente tutor di Storia Contemporanea e Storia dei Partiti e Movimenti politici.



 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dirigente amministrativa presso l’Università del Molise.
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dirigente amministrativa presso l’Università del Molise. Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica ed informatica presso l’Università degli Studi di Napoli. Ha Svolto attività didattica presso l’Università Federico II. Vive a Telese.
Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica ed informatica presso l’Università degli Studi di Napoli. Ha Svolto attività didattica presso l’Università Federico II. Vive a Telese. Vive a Morcone. Presidente Italia Nostra Matese Alto Tammaro.
Vive a Morcone. Presidente Italia Nostra Matese Alto Tammaro. Maestro elementare, appassionato studioso e cultore di Storia Locale.
Maestro elementare, appassionato studioso e cultore di Storia Locale.
 Biologo residente a Telese Terme. Cultore di storia locale con particolare riferimento alla storia del periodo sannitico. È autore del saggio “La Leonessa e il fenomeno luminoso nella grotta di Sant’Angelo” edito da Fioridizucca nel 2022.
Biologo residente a Telese Terme. Cultore di storia locale con particolare riferimento alla storia del periodo sannitico. È autore del saggio “La Leonessa e il fenomeno luminoso nella grotta di Sant’Angelo” edito da Fioridizucca nel 2022. Già sindaco di Caiazzo, dopo aver conseguito la maturità scientifica, rivolge il suo impegno politico alle battaglie del Partito Radicale, soprattutto nel campo della tutela dell’ambiente e in quello per una giustizia giusta. Nel 1980 viene eletto consigliere comunale a Caiazzo, città in cui vive, in rappresentanza della “nuova sinistra”. Nel 1982 aderisce alla Lega per l’Ambiente, promuovendo diverse iniziative per la tutela del fiume Volturno e per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Caiazzo. Tra il 1987 e il 1994 è Presidente dell’Associazione Storica del Caiatino. Nel 1994 viene eletto sindaco di Caiazzo con la lista civica “Rinascita Caiatina”. Rieletto nel 1998, si adopera per una crescita socio-economica della città; realizza un programma pluriennale, che viene selezionato anche da “Sviluppo Italia” SpA per la costituzione di un Laboratorio di sperimentazione per lo sviluppo locale. Presidente dell’Associazione “Città Paesaggio” dal 2003, è coordinatore del progetto “Per una Carta dei paesaggi dell’olio e dell’olivo”, realizzato d’intesa con l’Associazione nazionale “Città dell’Olio”. Nel 2007 aderisce a Slow Food, dedicandosi soprattutto alla salvaguardia delle piccole produzioni agricole. Ha pubblicato con le Edizioni 2000diciassette: La Memoria e L’Oblio, un saggio sull’eccidio di Caiazzo durante l’ultimo conflitto mondiale.
Già sindaco di Caiazzo, dopo aver conseguito la maturità scientifica, rivolge il suo impegno politico alle battaglie del Partito Radicale, soprattutto nel campo della tutela dell’ambiente e in quello per una giustizia giusta. Nel 1980 viene eletto consigliere comunale a Caiazzo, città in cui vive, in rappresentanza della “nuova sinistra”. Nel 1982 aderisce alla Lega per l’Ambiente, promuovendo diverse iniziative per la tutela del fiume Volturno e per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Caiazzo. Tra il 1987 e il 1994 è Presidente dell’Associazione Storica del Caiatino. Nel 1994 viene eletto sindaco di Caiazzo con la lista civica “Rinascita Caiatina”. Rieletto nel 1998, si adopera per una crescita socio-economica della città; realizza un programma pluriennale, che viene selezionato anche da “Sviluppo Italia” SpA per la costituzione di un Laboratorio di sperimentazione per lo sviluppo locale. Presidente dell’Associazione “Città Paesaggio” dal 2003, è coordinatore del progetto “Per una Carta dei paesaggi dell’olio e dell’olivo”, realizzato d’intesa con l’Associazione nazionale “Città dell’Olio”. Nel 2007 aderisce a Slow Food, dedicandosi soprattutto alla salvaguardia delle piccole produzioni agricole. Ha pubblicato con le Edizioni 2000diciassette: La Memoria e L’Oblio, un saggio sull’eccidio di Caiazzo durante l’ultimo conflitto mondiale. Giornalista Pubblicista. Esperto di Enologia, collabora a diversi siti web del settore. Collaboratore del blog lucianopignataro.it è responsabile dell’Ufficio Stampa del Sannio Consorzio Tutela Vini.
Giornalista Pubblicista. Esperto di Enologia, collabora a diversi siti web del settore. Collaboratore del blog lucianopignataro.it è responsabile dell’Ufficio Stampa del Sannio Consorzio Tutela Vini.  Dottore in Storia. Autore di un saggio storico, conseguente a ricerca d’archivio, sul suo Comune dal titolo: Faicchio 1920 – 1946 dall’avvento del Fascismo alla nascita della Repubblica, 2016.
Dottore in Storia. Autore di un saggio storico, conseguente a ricerca d’archivio, sul suo Comune dal titolo: Faicchio 1920 – 1946 dall’avvento del Fascismo alla nascita della Repubblica, 2016. Promotore culturale dell’area di Faicchio. Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato in Economia. È dirigente d’impresa a Milano nel settore delle borse valori e mercati finanziari. Ha scritto diversi articoli sulla stampa finanziaria nazionale, tra cui il Sole 24 Ore ed Investire. È appassionato di cultura locale, ha vinto il premio Prosa IX Premio letterario dell’Associazione Storica del Medio Volturno. Titolare delle strutture ricettive “Magie del Sannio” ha dato vita anche al “Piccolo Museo privato di Faicchio Magie del Sannio”.
Promotore culturale dell’area di Faicchio. Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato in Economia. È dirigente d’impresa a Milano nel settore delle borse valori e mercati finanziari. Ha scritto diversi articoli sulla stampa finanziaria nazionale, tra cui il Sole 24 Ore ed Investire. È appassionato di cultura locale, ha vinto il premio Prosa IX Premio letterario dell’Associazione Storica del Medio Volturno. Titolare delle strutture ricettive “Magie del Sannio” ha dato vita anche al “Piccolo Museo privato di Faicchio Magie del Sannio”. Giornalista professionista. Scrittore di romanzi e direttore di diverse testate radio televisive. Fondatore del sito: Neifatti.it
Giornalista professionista. Scrittore di romanzi e direttore di diverse testate radio televisive. Fondatore del sito: Neifatti.it Esperta di Comunicazione Istituzionale; in particolar modo di Social Media Policy e e di politiche agroalimentari legate all’economia di piccola scala per Slow Food, in Campania e Basilicata. Suoi contributi in ambito associativo sono legati a tradizioni e culture della terra e del territorio. Ha effettuato training in storiografia in Francia.
Esperta di Comunicazione Istituzionale; in particolar modo di Social Media Policy e e di politiche agroalimentari legate all’economia di piccola scala per Slow Food, in Campania e Basilicata. Suoi contributi in ambito associativo sono legati a tradizioni e culture della terra e del territorio. Ha effettuato training in storiografia in Francia. Infaticabile animatore culturale dell’area del Caiatino e del Casertano. Allievo del prof. Galasso. Fondatore di Gruppi culturali dediti alla divulgazione della storia del Territorio, attualmente responsabile di Procedimento Unità Operativa Biblioteca civica e Archivio Storico del Comune di Caiazzo.
Infaticabile animatore culturale dell’area del Caiatino e del Casertano. Allievo del prof. Galasso. Fondatore di Gruppi culturali dediti alla divulgazione della storia del Territorio, attualmente responsabile di Procedimento Unità Operativa Biblioteca civica e Archivio Storico del Comune di Caiazzo.
 Medico ed esperto di storia della gastronomia.
Medico ed esperto di storia della gastronomia. Medico di Emergenza territoriale residente in Puglianello. Ha collaborato all’opera Dieci Medici Raccontano.
Medico di Emergenza territoriale residente in Puglianello. Ha collaborato all’opera Dieci Medici Raccontano. Studioso della storia del Risorgimento e cultore del periodo Borbonico, ha recentemente collaborato con un suo scritto all’antologia biografica dedicata a Michele Ungaro. Ha in corso un saggio su Sanchez De Luna, un Vescovo del ‘700.
Studioso della storia del Risorgimento e cultore del periodo Borbonico, ha recentemente collaborato con un suo scritto all’antologia biografica dedicata a Michele Ungaro. Ha in corso un saggio su Sanchez De Luna, un Vescovo del ‘700. Medico specialista in oncologia e cure palliative è autore principalmente di pubblicazioni scientifiche di settore in lingua inglese ed italiana. È stato inoltre relatore
Medico specialista in oncologia e cure palliative è autore principalmente di pubblicazioni scientifiche di settore in lingua inglese ed italiana. È stato inoltre relatore Sannita di origini e toscano d’adozione. Medico anestesista, ha coltivato con interesse e particolarmente studiato la “Terapia del dolore”. Di tale disciplina è stato per lunghi anni docente all’Università di Siena. Ha avuto anche esperienze di insegnamento all’estero (Bobigny Paris nord, Accademia Russa delle Scienze mediche, Accademia Lettone di Scienze odontoiatriche). Ufficiale medico dell’Esercito italiano, è appassionato di esoterismo, di cultura e tradizioni popolari. E’ autore di saggistica. Ha recentemente pubblicato saggio su “Massoneria, relazioni umane e comunicazione tecnologica” edito da Fioridizucca edizioni.
Sannita di origini e toscano d’adozione. Medico anestesista, ha coltivato con interesse e particolarmente studiato la “Terapia del dolore”. Di tale disciplina è stato per lunghi anni docente all’Università di Siena. Ha avuto anche esperienze di insegnamento all’estero (Bobigny Paris nord, Accademia Russa delle Scienze mediche, Accademia Lettone di Scienze odontoiatriche). Ufficiale medico dell’Esercito italiano, è appassionato di esoterismo, di cultura e tradizioni popolari. E’ autore di saggistica. Ha recentemente pubblicato saggio su “Massoneria, relazioni umane e comunicazione tecnologica” edito da Fioridizucca edizioni. Dottore in Legge ed autore di ricerche di Storia Locale. Ha partecipato al progetto “Un museo a colori” avente il fine di far conoscere il museo di arte ceramica di Cerreto Sannita. Le mansioni svolte sono state quelle di guida museale e bibliotecaria, e redazione di progetti e lavori di gruppo con gli altri volontari. Ha scritto un saggio nella Antologia dedicata al bicentenario della nascita di Michele Ungaro, edita dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita.
Dottore in Legge ed autore di ricerche di Storia Locale. Ha partecipato al progetto “Un museo a colori” avente il fine di far conoscere il museo di arte ceramica di Cerreto Sannita. Le mansioni svolte sono state quelle di guida museale e bibliotecaria, e redazione di progetti e lavori di gruppo con gli altri volontari. Ha scritto un saggio nella Antologia dedicata al bicentenario della nascita di Michele Ungaro, edita dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita.
 Andrea Ciervo nato a Caserta il 12.10.1975. Presbitero dal 24 novembre 2012 già Laureato in Giurisprudenza alla Federico II, con una tesi di Diritto Ecclesiastico sui Risvolti dei Patti Lateranensi col prof. Mario Tedeschi…tirocinante poi presso Studio Notaro in via Mezzocannone di Napoli…consegue il Baccalaureato presso l’Aloysianum di Padova nel 2007 con una tesi sulla Religione in Immanuel Kant col prof. Secondo Bongiovanni. Si Laurea in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell’ Italia Meridionale sezione san Tommaso nel 2012 sempre “Summa cum laude”
Andrea Ciervo nato a Caserta il 12.10.1975. Presbitero dal 24 novembre 2012 già Laureato in Giurisprudenza alla Federico II, con una tesi di Diritto Ecclesiastico sui Risvolti dei Patti Lateranensi col prof. Mario Tedeschi…tirocinante poi presso Studio Notaro in via Mezzocannone di Napoli…consegue il Baccalaureato presso l’Aloysianum di Padova nel 2007 con una tesi sulla Religione in Immanuel Kant col prof. Secondo Bongiovanni. Si Laurea in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell’ Italia Meridionale sezione san Tommaso nel 2012 sempre “Summa cum laude” Dottore in Archeologia e Scienze Storiche, ha svolto diverse campagne di scavo alla necropoli del Cigno a Macchia Valfortore (CB), con l’Università degli studi di Napoli Federico II e alla necropoli di Crocifisso del tufo a Orvieto (TR), con il Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano e l’ Università dell’Arizona. È attuale vice Presidente della Pro Loco di Sant’Agata dei Goti (BN) dove svolge anche la funzione di OLP per il Servizio Civile Universale. È giornalista tirocinante presso la testata QuasiMezzogiorno. Sì è occupato di alcuni ambiti di archeologia della produzione del Sannio caudino. Attualmente s’interessa alle istituzioni sociali e militari del Medioevo. È vice Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino.
Dottore in Archeologia e Scienze Storiche, ha svolto diverse campagne di scavo alla necropoli del Cigno a Macchia Valfortore (CB), con l’Università degli studi di Napoli Federico II e alla necropoli di Crocifisso del tufo a Orvieto (TR), con il Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano e l’ Università dell’Arizona. È attuale vice Presidente della Pro Loco di Sant’Agata dei Goti (BN) dove svolge anche la funzione di OLP per il Servizio Civile Universale. È giornalista tirocinante presso la testata QuasiMezzogiorno. Sì è occupato di alcuni ambiti di archeologia della produzione del Sannio caudino. Attualmente s’interessa alle istituzioni sociali e militari del Medioevo. È vice Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino. Medico di Pronto Soccorso ed Emergenza Cultore di Storia Locale ha scritto il saggio: Telesia 1349 Peste e Terremoto edizioni duemiladicessette, 2016, Cartoline da Telese ed. Unione Filatelica Beneventana, 2009; Castelvenere Valdese insieme a P. Carlo Ed. Realtà Sannita, 2016; Officine Massoniche e Vendite Carbonare in Area Sannita insieme a F. Pace, edito dall’ASMV nel 2019. Ha scritto nell’Antologia sulla vita di Michele Ungaro edito dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita nel 2019.ha in corso di pubblicazione un libro di poesie. Dirige la collana di poesie della Casa Editrice FioriDiZucca. Presidente pro-tempore dell’Istituto Storico del Sannio Telesino. Premio Upupa 2017 e 2019 per gli studi di storia locale.
Medico di Pronto Soccorso ed Emergenza Cultore di Storia Locale ha scritto il saggio: Telesia 1349 Peste e Terremoto edizioni duemiladicessette, 2016, Cartoline da Telese ed. Unione Filatelica Beneventana, 2009; Castelvenere Valdese insieme a P. Carlo Ed. Realtà Sannita, 2016; Officine Massoniche e Vendite Carbonare in Area Sannita insieme a F. Pace, edito dall’ASMV nel 2019. Ha scritto nell’Antologia sulla vita di Michele Ungaro edito dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita nel 2019.ha in corso di pubblicazione un libro di poesie. Dirige la collana di poesie della Casa Editrice FioriDiZucca. Presidente pro-tempore dell’Istituto Storico del Sannio Telesino. Premio Upupa 2017 e 2019 per gli studi di storia locale.